“Noi siamo i figli di mezzo della storia, cresciuti dalla televisione a credere che un giorno saremo milionari e divi del cinema e rockstar, ma non andrà così. E stiamo or ora cominciando a capire questo fatto”. Tyler Durden.
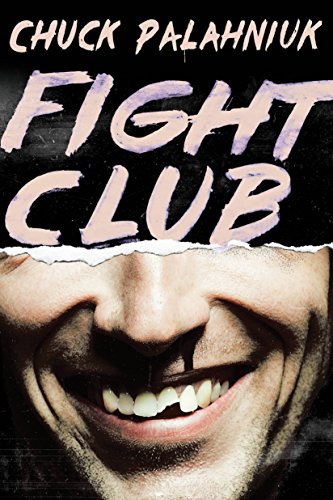
Il lettore che ha già visto il bellissimo film, per la regia di David Fincher, può intuire facilmente perché scrivo una recensione del romanzo di Palahniuk per una rivista che parla di psicologia. In questo caso è sicuramente più gradevole, e agevole, vedere l’opera cinematografica che leggere il libro contrariamente a quanto si è soliti sperimentare. A parte il soggetto però, film e libro non hanno molto in comune, a partire dalla sequenza temporale degli avvenimenti fino a differenze importanti di trama. Quello che però condividono totalmente è l’ambiente, il contesto in sui si svolge tutta la vicenda dei protagonisti. L’America, quella urbana, metropolitana, consumistica, nichilista, assolutamente priva di scopo se non nel valorizzare ed inseguire il possesso di oggetti e appunto di beni di consumo. “Alla fine sono loro che possiedono te” dice il protagonista durante il film. Nel libro invece questo concetto si manifesta implicitamente, attraverso il racconto di una vita routinaria e frenetica dedita ad un lavoro che non dà senso ma che aliena da tutto, attuando una nemesi marxista nel paese del “sogno”. Il lavoro come mezzo per arrivare a consumare, il consumo come scopo di vita, la vita consumata di corsa per guadagnare qualcosa che permetta di comprare, consumare e quindi vivere. Nient’altro. Non di semplice lettura, con una scrittura ripetitiva, cupa, violenta, fatta di slang e slogan pubblicitari. A tratti ipnotica, come ipnotica è la personalità di Tyler che riesce a unire intorno a sé tutta la quinta casta del mondo occidentale, tutti i reietti dell’urbanizzazione e del consumismo. C’è azione senza esserci racconto, c’è affetto pur essendoci solo sesso brutale. C’è dolore, paura, rabbia, emozioni presenti senza mai essere nominate. L’autore riesce ad essere profondo rimanendo sempre in superfice. I personaggi sono degli “evitanti” che darebbero la vita per l’altro, per il loro compagno, camerata o amico antropomorfo. C’è cameratismo ma non “leccaculismo” vicendevole. Il linguaggio è rude, violento, minimalista, fastidioso ed essenziale. Un clima perennemente noir, dove ossimorica insonnia ipnotica la fa da padrone e non permette di distinguere la veglia dal sonno; ci si ritrova in uno stato di coscienza sfumato, senza confini e soluzione di continuità. Da questa condizione emerge, paradossalmente viva, la malattia unico fugace motivo di scambio di umanità. Ci si incontra solo da malati e tra malati, ci si abbraccia, ci si tocca, si condivide, si piange solo se si ha un male che con ogni probabilità accorcerà la nostra agonia terrena. Si è costretti a fingersi malati per incontrare un altro essere umano: l’apoteosi della nevrosi. Questo fino a quando non incontriamo il nostro alter ego, qualcuno che ci apre gli occhi, che ci fa vedere ciò che nascondiamo a noi stessi, che agisce così come noi vorremo agire se fossimo come lui e se avessimo il suo coraggio. Il coraggio di combattere; non in senso metaforico, o almeno non solo. Combattere non per una causa giusta o per fare la rivoluzione ma semplicemente per il piacere di farlo, per sentirsi vivi. Non per raggiungere chissà quale ideale, raggiunto il quale ci ritroveremmo nella stessa situazione di prima, a cercare di raggiungerne un altro, e un altro ancora, come una specie di Sisifo che reifica tutto e tratta come oggetto qualsiasi scopo umano, anche la felicità. Già, vi si scorge la reificazione di qualsiasi relazione, tutto diventa roba da consumare, con un processo di divinizzazione al contrario, in cui un naturale afflato diventa oggetto da acquistare. C’è la classica inversione mezzi fini, non come sofisma logico ma come distorsione esistenziale. Ad un certo punto del romanzo, ti viene voglia di uscire di casa e prendere a pugni il tuo vicino di casa che ha il cane che ulula ad ogni passaggio di sirena. Ecco, mi sono lasciato trascinare anch’io! Sarà il fascino di Tyler?


Devi effettuare l'accesso per postare un commento.